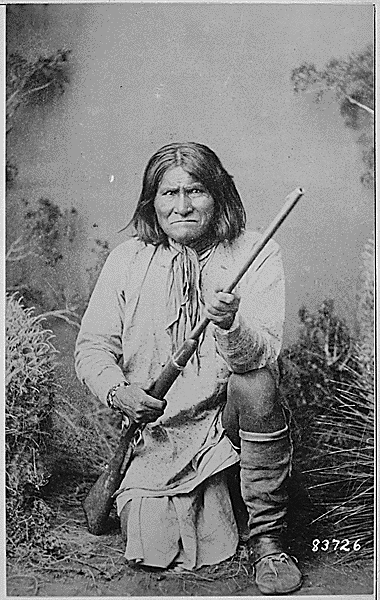Giusto e sbagliato *
lunedì 12 dicembre 2016
Riscoprire i valori perduti
RISCOPRIRE I VALORI PERDUTI
Quest’anno , anno santo della
misericordia, voglio intrattenere chi legge sull’ importanza, almeno per me, di
riscoprire i valori smarriti della vita.
“Nel mondo di oggi ciò di cui
abbiamo bisogno è un gruppo di uomini e donne decisi a schierarsi dalla parte
del giusto ed opporsi all’ingiusto, dovunque si verifichi. Un gruppo di persone
che abbiano capito che alcune cose sono ingiuste, anche se non vengono mai
scoperte. Alcune cose sono giuste, anche se nessuno ti vede mentre le fai.
Voglio dire soltanto che il nostro mondo poggia su cardini del
fondamento morale. Dio lo ha fatto così. E’ stato Dio a fare l’universo fondato su una legge morale…
Questo universo è incardinato sulle fondamenta della morale . In questo
universo c’è qualcosa che giustifica queste frasi: “ nessuna menzogna può vivere per sempre” , oppure , “ La verità che è stata schiacciata a terra
tornerà a sollevarsi” , ancora, “ Raccoglierete quel che seminate” .
Quando ero giovane, e avevo davanti a me la maggior parte della vita,
decisi di donare fin dal principio la mia vita a qualcosa di eterno e di
assoluto. Non a questi piccoli dei, che oggi ci sono e domani non ci sono più. No: a Dio che è lo stesso ieri, oggi,
sempre.
Se vogliamo andare avanti, dobbiamo tornare indietro e riscoprire
questi valori preziosi: che tutta la realtà è incardinata su fondamenti morali
e tutta la realtà è soggetta al dominio dello spirito.”
Ogni
tanto immagino, tutti noi pensiamo in modo realistico al giorno in cui
resteremo vittime di quello che è il definitivo comune denominatore della vita:
quella cosa che chiamiamo morte. tutti noi ci pensiamo. E di tanto in tanto io
penso alla mia morte, e penso al mio funerale. Di tanto in tanto mi domando: “
Che cosa vorrei che dicessero?”.
DEMOCRAZIA DIRETTA - SVIZZERA
Campioni
delle urne, la Svizzera è la patria della democrazia diretta
In media, gli svizzeri vanno a votare
quattro volte l’anno. Il popolo è sovrano e può votare sulle leggi del
Parlamento e le modifiche costituzionali. Fino alle votazioni per alzata di mano
in alcuni cantoni
L’ultimo è stato il referendum sul reddito minimo per tutti,
bocciato dal 78% dei votanti. Se c’è un Paese dove il popolo è sovrano, questo
è la Svizzera. Nella
confederazione dei 26 piccoli staterelli, detti cantoni, i cittadini partecipano
direttamente al processo decisionale politico. In media, vanno a votare almeno quattro
volte l’anno sui
temi più disparati, dal raddoppio delle gallerie alla discriminazione della
famiglia tradizionale. Le consultazioni propositive o abrogative sono continue,
per questioni federali, cantonali o comunali. Le piccole dimensioni del
territorio, unite al numero ridotto degli abitanti (8 milioni) e alle grandi
differenze interne, hanno favorito questa formula detta di democrazia semidiretta o semirappresentativa.
Significa che democrazia diretta e democrazia rappresentativa
convivono. Gli svizzeri eleggono ogni quattro anni i 200 membri del Parlamento,
che ha il potere legislativo. Ma il popolo ha la sovranità delle decisioni
politiche dello Stato. Per cui può esprimersi su tutte le leggi, e deve votare
su qualsiasi revisione della Costituzione. I due strumenti a disposizione degli
svizzeri sono il referendum e l’iniziativa
popolare.
Ogni modifica della Costituzione federale e ogni adesione dello
Stato a un’organizzazione internazionale è sottoposta a referendum obbligatorio. Il quorum non esiste. Ma
per essere approvato, il testo deve avere la doppia maggioranza del popolo e
dei cantoni. Nel 2001, ad esempio, si votò a larga maggioranza per introdurre
il pareggio di bilancio in Costituzione, in modo da far fronte alla crescita
del debito pubblico. L’anno dopo, nel 2002, si votò invece per l’ingresso nelle
Nazioni Unite.
In qualità di aventi diritto di voto, se si vuole modificare la
Costituzione, ogni svizzero può lanciare un’iniziativa popolare:
basta raccogliere 100mila firme in 18 mesi. Contrariamente a quanto succede nei
Cantoni, a livello federale però con una iniziativa popolare non si può
chiedere una nuova legge o una modifica a una legge già esistente. Le iniziative
pendenti di modifica della Costituzione in fase di raccolta firme a fine giugno vanno dal congedo di paternità
“ragionevole” al divieto dissimulare il proprio viso, dallo stop
alla “dispersione degli insediamenti” all’autodeterminazione contro l‘ingerenza
dei “giudici stranieri”.
Prima
di essere sottoposta a votazione popolare, l’iniziativa passa al vaglio del
governo e del Parlamento. Se la proposta divide il Parlamento, il processo può
durare anche diversi anni. Se il Parlamento riconosce la legittimità delle
rivendicazioni dell’iniziativa, ma non condivide la soluzione, può opporle un
controprogetto. Magari più moderato. Può anche succedere però che il comitato
promotore dell’iniziativa sia soddisfatto del controprogetto e decida di
ritirare il proprio testo. In questo caso l’iniziativa non è sottoposta a
votazione popolare. Dal 1987, nelle votazioni popolari sulle iniziative è
possibile approvare sia l’iniziativa sia il controprogetto. E con una domanda
risolutiva si stabilisce poi quale dei due testi deve entrare in vigore nel
caso in cui entrambi ottengano la maggioranza dei votanti e dei cantoni.
A questi strumenti della democrazia diretta ricorrono spesso formazioni politiche e sociali che faticano a ottenere una
maggioranza nel Parlamento. Si tratta spesso della sinistra,
sui temi economico e sociale, e della desta più conservatrice, per temi legati
all’identità nazionale e agli stranieri. Che spesso assumono derive populiste.
Succede però anche che a farne uso siano piccole associazioni o privati
cittadini, che difficilmente riescono però nel loro obiettivo.
Le iniziative popolari, però, si rivelano utili per lanciare
dibattiti su argomenti che altrimenti non verrebbero trattati dal Parlamento. E
in alcuni casi i promotori riescono a veder soddisfatte parte delle loro
rivendicazioni, tramite la produzione del controprogetto parlamentare. Ma ci
sono anche casi, seppur rari, in cui le iniziative bocciate dalla maggioranza
del Parlamento ottengono la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un esempio:
l’iniziativa che consente agli azionisti di influire sulle
rimunerazioni dei top manager, promossa dal piccolo
imprenditore Thomas Minder, è stata approvata nella votazione federale del 3
marzo 2013, con il sì di circa il 68% dei votanti e di tutti i cantoni.
Altra cosa è il referendum facoltativo.
Se il Parlamento approva una nuova legge, la popolazione di regola non viene
chiamata alle urne. Se però vengono raccolte 50mila firme di aventi diritto al
voto, oppure otto cantoni chiedono di votare nell’arco di cento giorni, allora
si andrà a votare. Il referendum facoltativo dà la
facoltà agli oppositori del testo di farlo sottoporre a votazione popolare. Al
momento, ad esempio, sono
in fase di raccolta firme 33 referendum facoltativi,
che riguardano decreti che vanno dal lavori nei trasporti pubblici alla
registrazione delle malattie tumorali.
Ma nonostante il coinvolgimento della popolazione nelle
decisioni sia così alta, la partecipazione degli
svizzeri agli appuntamenti elettorali tutto sommato è piuttosto bassa. Certo,
varia molto in base al tema, ma raramente si supera il 40 per
cento. Ma il quorum non esiste. E il risultato del referendum è
sempre valido, a prescindere da quante persone abbiano votato.
E poi si arriva anche alle forme più spettacolari di democrazia
diretta. Nelle votazioni di piazza nei piccoli cantoni rurali dell’Appenzello
Interno e Glarona, tutti i cittadini che godono del diritto di voto si
riuniscono in assemblea in una piazza e votano per alzata di mano per
eleggere amministratori e deliberare leggi locali.
Ma
nonostante la spettacolarità di alcuni casi e le derive populistiche di altri,
la democrazia diretta resta uno dei pilastri del modello svizzero. La classe
politica sente la pressione della popolazione e procede con attenzione, sia
nella spesa del denaro pubblico sia nella produzione legislativa sui temi caldi.
I cittadini sono continui controllori della classe politica. In ogni momento
una decisione popolare può bloccare i lavori e rimettere in discussione
l’operato politico.
LA DEMOCRAZIA DIRETTA
LA DEMOCRAZIA DIRETTA
La storia della
democrazia diretta viene giustamente fatta iniziare con l’esperienza della
Grecia di Atene grosso modo dal 400 al 320 a.C. Non ci sono dubbi che i
cittadini ateniesi avessero e utilizzassero la possibilità di esprimersi
direttamente con la discussione e con il voto sulle tematiche di interesse per
la loro città e di decidere. «Direttamente» si esprimevano con un voto per
espellere, per periodi più o meno lunghi, ma anche definitivamente, coloro che
avessero malmeritato, violando le leggi: l’ostracismo. L’esperienza politica
importante dopo quella ateniese non fu tecnicamente «democratica» per un
insieme di ragioni, ma soprattutto per le limitazioni al numero dei
partecipanti e all’attribuzione del potere politico. Tuttavia, nella Roma
repubblicana si tennero elezioni, vi fu rappresentanza politica, si ebbe
ricambio regolare nella leadership. Non vi furono, invece, modalità
di democrazia diretta. Saltando una lunga fase, sicuramente di eclissi non
soltanto della democrazia, ma anche della politica, i Comuni , in Italia
più che altrove, ebbero forme di politica e di rappresentanza, ma non di
democrazia diretta, vale a dire, di possibilità per la cittadinanza di prendere
collettivamente decisioni importanti. Né queste decisioni vennero concesse ai
cittadini della florida e ben governata Repubblica di Venezia.
Colui che argomentò
vigorosamente la necessità della democrazia diretta, senza dubbio influenzato
dal contesto in cui viveva, fu l’illuminista ginevrino J.-J. Rousseau
(1712-1778). Non soltanto ritenne che la democrazia non potesse che esprimersi
in forma di partecipazione personale e diretta, che garantiva e manteneva la
libertà di tutti e consentiva la formazione della volontà generale, ma rafforzò
la sua preferenza (e formulazione) criticando la democrazia degli inglesi,
l’unica allora effettivamente esistente. Rousseau affermò sarcasticamente che
gli inglesi si credevano liberi perché votavano per eleggere i loro
rappresentanti. Ma, liberi soltanto una volta ogni cinque anni, erano
sottomessi al potere politico per tutto il resto del tempo. In verità, Rousseau
si sbagliava. Gli inglesi erano liberi anche nel periodo che intercorreva fra
le elezioni. Potevano associarsi, protestare, fare giungere critiche, sollecitazioni
e proposte ai loro rappresentanti. Ma la loro certamente fu, fin dagli inizi,
ed è rimasta rigorosamente e convintamente una democrazia parlamentare e
rappresentativa. Gli inglesi, segnatamente E. Burke (1729-1797), guardarono con
preoccupazione e deplorazione ai tentativi effettuati dai rivoluzionari
giacobini di introdurre in Francia forme di democrazia diretta, peraltro, di
breve e non brillante durata. Infatti, come sottolineò F. Furet, il linciaggio
a furor di popolo degli aristocratici e dei preti nel settembre 1792, fu l’atto
finale della democrazia diretta, consegnata alla Costituzione giacobina sotto
forma di mandati corti dei rappresentanti e di assemblee popolari per la
ratifica delle leggi. Venne rapidamente sostituita dalla democrazia rappresentativa,
ovvero dalla Convenzione che si assunse la responsabilità di emanare la
condanna a morte del sovrano Luigi XVI nel gennaio 1793. Curiosamente, fu
sulle altre rive dell’Atlantico, nella nascente democrazia USA, che inglesi,
dissenzienti religiosi e loro discendenti, fecero ampio ricorso alla democrazia
diretta. I fedeli e i credenti si riunivano nelle loro chiese e nelle loro
piazze dove, dopo scambi di idee e dibattiti anche accesi, decidevano,
direttamente. Rapidamente, in quelle stesse comunità, spesso piccole, coese e
piuttosto omogenee, dal punto di vista religioso e sociale, furono i cittadini
a chiamarsi a raccolta, a consultarsi, a riunirsi dando vita ai
cosiddetti town meeting. Queste modalità di democrazia diretta non
sono mai del tutto venute meno negli Stati Uniti d’America. Nel contesto
europeo, di lenta democratizzazione e di faticosa affermazione della democrazia
parlamentare, la rappresentanza prese il sopravvento su quel poco che c’era
stato, tranne in Svizzera, di democrazia diretta. L’ultima, grande e vivida
fiammata di democrazia diretta si ebbe, con la benedizione di K. Marx, nella
Comune di Parigi (marzo-maggio 1871), breve e tragico esperimento di
autogoverno, nel corso del quale venne anche introdotto un principio, già circolante
nel contesto USA: quello della revoca (rappel, recall) degli
eletti. Rimanendo in Europa, è la Rivoluzione bolscevica che sembrò aprire
nuovi spazi e grandi opportunità alla democrazia diretta con la creazione dei
consigli (Soviet) dei contadini e degli operai (anche dei marinai nella
breve epopea dell’insurrezione di Kronshtadt). Sarebbe, però, stato
davvero sorprendente se quell’accentratore di V.I. Lenin avesse proceduto lungo
la strada della democrazia diretta, d’altronde non presente neppure nel
pensiero politico di L.D. Trockij. Anche se in Europa, sia a Monaco di Baviera
(1919) sia a Torino (1920), vi furono imitazioni di consigli operai
rivoluzionari accompagnati da autogestione delle fabbriche, qualsiasi velleità
rimasta di democrazia diretta venne spenta in Unione Sovietica dall’ascesa di
I.V. Stalin. Il partito unico è totalitario: altri spazi politici sono
inesistenti. Al di fuori del partito nessuna attività politica è concessa.
Dentro il partito rimane il centralismo democratico ovvero il dominio della
segreteria, il centro, sulla democrazia.
Nella maniera che si
conviene a una democrazia decentrata, cangiante ed effervescente, elementi di
democrazia diretta continuavano a sussistere un po’ dappertutto sul territorio
statunitense. Nessuna ricognizione è possibile proprio per la manifestazione
spontanea e non regolamentata di quelle esperienze. Volendo, si potrebbe
tornare alla famosa dichiarazione di A. Lincoln a Gettysburg (1863) sulla
democrazia: «government of the people, by the people, for the people». Il
popolo si esprime attraverso (of) le elezioni, ma può anche governare
direttamente (by) e il governo deve perseguire l’interesse (for)
del popolo. L’affermazione e il consolidamento della democrazia parlamentare
rappresentativa fatta funzionare dai partiti, essenziali a una democrazia di
questo tipo, cancellò, tranne che in Svizzera (incidentalmente, caso
di democrazia federale con forma di governo direttoriale), qualsiasi
«residuo» di democrazia diretta. D’altronde, nelle democrazie dei grandi numeri
di elettori, per di più, almeno fino al secondo dopoguerra, con basso livello
di istruzione, la rappresentanza attraverso i partiti era l’unica garanzia che
interessi e preferenze della maggior parte degli elettori venissero
effettivamente presi e tenuti in considerazione dagli uomini di partito, dai
loro candidati e dai loro eletti, tutti interessati alla rielezione. Di
democrazia diretta non si parlò praticamente più per un periodo di diversi
decenni, anche se con pochi politici e qualche studioso caddero
nell’equivoco, più o meno voluto e consapevole, di identificare la democrazia
diretta con l’elezione (popolare) diretta dei capi degli esecutivi, in
primis, dei presidenti delle repubbliche latino-americane. Non è così. Ed è
egualmente sbagliato pensare che la democrazia partecipativa non possa che
essere democrazia diretta. Molte democrazie parlamentari rappresentative sono
innervate da solide reti di associazioni, partiti compresi e spesso centrali,
che garantiscono ampie possibilità di partecipazione politica. Comunque, tutte
le democrazie sono, in qualche misura, partecipative: i cittadini partecipano
alle elezioni, oltre che, ogniqualvolta lo desiderino, a qualsiasi attività
politica associandosi e manifestando, in una pluralità di forme, approvazione o
contestazione. Non è probabilmente casuale che la richiesta di forme e di
modalità di democrazia diretta abbia fatto la sua ricomparsa con i movimenti
del Sessantotto. Da un lato, si affacciava alla politica una nuova generazione,
quella dei babyboomer nati dopo la Seconda guerra mondiale e
cresciuti in un periodo di grandi opportunità, aspettative, speranze, nonché
attrezzati con un più elevato livello di istruzione. Dall’altro, cominciava a
manifestarsi la crisi dei partiti e della loro capacità di comprensione delle
nuove domande politiche, non più soltanto ordine e sicurezza e stabilità dei
prezzi, ma anche libertà di parola e opportunità di autorealizzazione. Il
segnale più forte e più evidente di ricomparsa della democrazia diretta avviene
in due situazioni, lontane fra loro e per questo particolarmente significative:
l’Italia e la California. Nel 1970, la legge attuativa del referendum,
ancorché soltanto abrogativo, aprì la strada in Italia a una lunga
stagione referendaria cominciata nel 1974, ma probabilmente giunta a
esaurimento nel 2009: 62 referendum svoltisi nell’arco di 35
anni. In California, il referendum è più correttamente un’iniziativa
legislativa popolare che viene sottoposta da un certo numero di elettori (ma,
oggi, da potenti lobbies in grado di raccogliere le firme
necessarie) a tutti gli elettori. La nuova fase iniziò con la dirompente Proposition
13 che ridusse significativamente le tasse sulle proprietà immobiliari
e che, incidentalmente, aprì la strada alla «rivoluzione neoconservatrice» del
futuro presidente R. Reagan. Continua con la possibilità di «mettere» sulle
schede elettorali per tutte le consultazioni importanti tematiche da decidere
per via referendaria (di recente, la più frequentemente inserita è il matrimonio
fra persone dello stesso sesso). La maggior parte delle democrazie
parlamentari (e semipresidenziali) europee sono rimaste relativamente estranee
a spinte e fenomeni di democrazia diretta. Tuttavia, praticamente ovunque in
Europa si sono avuti referendum, in particolare concernenti
tematiche europee, adesione e approvazione dei trattati. Persino la patria del
modello Westminster, nella quale il Parlamento è sovrano, ha delegato agli
elettori attraverso un referendum tenuto nel 1975 la sua
adesione all’allora Comunità economica europea.
Dal punto di vista della
teorizzazione, hanno fatto la loro comparsa almeno due fenomeni di notevole
rilevanza: da un lato, la democrazia deliberativa, dall’altro, il bilancio
partecipativo. La prima è essenzialmente uno strumento complesso e delicato che
mira a raccogliere le preferenze dei cittadini, a istruirli, a plasmare una
decisione largamente condivisa attraverso forme di coinvolgimento e modalità di
apprendimento e di decisione. Ovviamente, il livello di applicazione è quello
delle comunità municipali. Il bilancio partecipativo è, invece, davvero uno
strumento di democrazia diretta con il quale i cittadini decidono come, a quali
attività, in che modo devolvere una parte del bilancio della loro
comunità.
Infine, secondo alcuni,
la democrazia diretta sta finalmente per diventare possibile grazie alla
disponibilità degli strumenti tecnologici più avanzati e moderni. Mentre,
comunque, negli USA ritornano alla ribalta veri e propri town meeting,
almeno come situazione nella quale gli eletti, persino il presidente B. Obama,
accettano di partecipare e confrontarsi oppure, addirittura, li fanno
organizzare, la California ha nuovamente offerto un esempio della effervescenza
(e volubilità) della sua politica producendo nel 2003 il secondo esempio di
revoca (recall) popolare di un governatore in carica. L’unico altro caso
si verificò in precedenza nel Nebraska nel 1921. Grazie a Internet sembra
diventare possibile una sorta di agorà telematica nella quale i cittadini, con
un minimo di digital divide, vale a dire di diseguaglianza fra
categorie – giovani e anziani, istruiti e no, che hanno accesso e possibilità
differenziate –, godono della enorme opportunità di comunicare fra loro, per
es., con i blog, e, eventualmente, persino di decidere in tempo
reale. Grandi sono i rischi per una democrazia che non sia soltanto diretta, ma
anche «istantanea». E, anche chi voglia andare oltre ovvero, piuttosto,
arricchire la democrazia rappresentativa, sente che si pone il problema: ma
la democrazia è decisione oppure è «conversazione per la decisione»?
Iscriviti a:
Post (Atom)